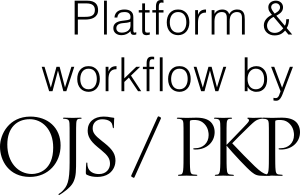Il ruolo delle preposizioni nella percezione del mondo. Analisi cognitiva del confronto di alcuni casi in italiano e polacco
DOI :
https://doi.org/10.31261/NEO.2024.36.05Mots-clés :
Perception of space, Cognitive Grammar, construal, trajector/landmark alignment, prepositionRésumé
Questo testo si propone di analizzare il ruolo delle preposizioni italiane e polacche nel processo di percezione del mondo o, in questo caso, di un confronto tra i due sistemi linguistici e concettuali. Le preposizioni sono elementi lessicali trattati in modi diversi negli studi linguistici: alcuni ricercatori sostengono che la preposizione sia semanticamente vuota, anzi, la sua funzione sia quella di unire due elementi o strutture linguistiche in una frase; altri dicono che abbia alcune caratteristiche semantiche. Esistono molti esempi di espressioni in italiano e polacco (o in altre lingue) in cui le frasi preposizionali differiscono nelle traduzioni, ossia alcune preposizioni sono intraducibili (non hanno un equivalente lessicale) e alcune non vengono tradotte con l'uso dei loro cosiddetti equivalenti. In alcune lingue naturali le preposizioni sono usate meno frequentemente o offrono maggiori possibilità di utilizzo, oppure una data lingua fornisce altri strumenti linguistici per esprimere lo stesso significato.
In questo contributo la base per le considerazioni è principalmente la teoria della Grammatica Cognitiva di Ronald W. Langacker (1987, 1991a, 1991b, 1995, 2000, 2008), con la sua nozione centrale di “construal” (precedentemente nota come “imagery” ), e le sue dimensioni, in particolare la prominenza con la distinzione dell'allineamento traiettore/landmark. L'analisi delle preposizioni, indipendentemente dalla lingua esaminata, può essere vasta e complessa; pertanto, qui presenteremo esempi (in italiano e polacco) di espressioni selezionate, ovvero quelle più interessanti e contrastanti.
Références
Bartmiński, J. (1993). O profilowaniu i profilach raz jeszcze. In: J. Bartmiński & R. Tokarski (a cura di), O definicjach i definiowaniu (269–275). UMCS.
Bartmiński, J. (a cura di) (1999). Językowy obraz świata. UMCS.
Bartmiński, J. & Tokarski, R. (1998). Profilowanie w języku i w tekście. UMCS.
Dardano, M. & Trifone, P. (2003). Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Zanichelli.
Di Tommaso, V. (1996). Preposizioni e espressioni locative: un’analisi semantica. Studi italiani di linguistica teorica e applicata 25(2), 257–290.
Gaeta, L. & Luraghi, S. (2003). Introduzione. In: L. Gaeta & S. Luraghi (a cura di), Introduzione alla linguistica cognitiva (17–35). Carocci.
Kosz [Paliczuk], A. (2005). Occhio all’italiana – cioè l’immagine linguistica del mondo italiano. Neophilologica 17, 177–186.
Kosz [Paliczuk], A. (2006). L’immaginare. I profili dell’occhio nelle lingue: italiana, polacca ed inglese. Linguistica Silesiana 27, 105–115.
Kosz [Paliczuk], A. (2008). Il passo dal pensiero alla lingua – l’analisi cognitiva della STRADA nella lingua italiana. Neophilologica 20, 124–141.
Kosz [Paliczuk], A. (2009). Rapporto tra tempo e spazio sull’esempio di alcune preposizioni italiane: un’analisi cognitiva. Tempo e memoria nella lingua e nella letteratura italiana, Atti del XVII Congresso A.I.P.I. Ascoli Piceno, 22–26 agosto 2006, Vol. I: Linguistica e didattica, Pubblicazioni dell’Associazione Internazionale Professori d’Italiano, Nuova serie 5, 87–99.
Kwapisz-Osadnik, K. (2017). Przyimki jako znaczniki różnych konceptualizacji: analiza zagadnienia na przykładzie języka włoskiego. Acta Neophilologica 19(1), 135–145.
Kwapisz-Osadnik, K. (2022). Diverse concettualizzazioni delle relazioni attraverso preposizioni neutre in italiano. Un approccio cognitivo. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Langacker, R. W. (1982). Space Grammar, Analysability, and English Passive. Language 58, 22–80.
Langacker, R. W. (1987). Foundations of Cognitive Grammar. Theoretical Prerequisites. Vol. 1. Standford University Press.
Langacker, R. W. (1991a). Concept, Image, And Symbol. The Cognitive Basis of Grammar. Mouton De Gruyter.
Langacker, R. W. (1991b). Foundations of Cognitive Grammar, Descriptive Application. Vol. 2. Standford University Press.
Langacker, R. W. (1995). Wykłady z gramatyki kognitywnej. UMCS.
Langacker, R. W. (2000). Grammar and Conceptualization. Mouton de Gruyter.
Langacker, R. W. (2008). Cognitive Grammar. A Basic Introduction. Oxford University Press. Trad.: E. Tabakowska, M. Buchta, H. Kardela et al. (2009). Gramatyka Kognitywna. Wprowadzenie. Universitas.
Laskowski, R. (1984). Podstawowe pojęcia morfologii. In: R. Grzegorczykowa, R. Laskowski & H. Wróbel (a cura di), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia (9–57). PWN.
Malinowska, M. (2005). Il ruolo degli schemi iconici (parte-tutto, percorso, punto iniziale, contenitore, supporto e contiguità) nella semantica preposizionale in italiano. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Malinowska, M. (2020). La preposizione su e alcuni suoi corrispettivi polacchi – uno studio cognitivo. Kwartalnik Neofilologiczny 67, 40–52.
Milewski, T. (1965). Językoznawstwo. PWN.
Paliczuk, A. (2014). Spazio – pensiero – lingua. La concettualizzazione della ‘città’ in italiano. Neophilologica 26, 298–309.
Pastucha-Blin, A. (2005). La concettualizzazione della nozione di fede nella lingua italiana. In: B. K. Bogacki & A. Dutka-Mańkowska (a cura di), Les relations sémantiques dans le lexique et dans le discours (245–256). Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
Przybylska, R. (2002). Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej. Universitas.
Saloni, Z. (1974). Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich. Język Polski 54, 3–13, 93–101.
Serianni, L. (1991). Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria. UTET Libreria.
Tabakowska, E. (1999). Gramatyka i obrazowanie. Wprowadzenie do językoznawstwa kognitywnego. PAN „Nauka dla wszystkich”.
Tabakowska, E. (2001). Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu. Universitas.
Wróbel, H. (1995). Co to są leksemy funkcyjne?. In: M. Grochowski (a cura di), Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście (7–16). Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
Les propriétaires des droits d'auteur du texte soumis sont l'auteur et l'éditeur. Le lecteur a le droit d'utiliser les documents pdf selon les termes de la licence internationale Creative Commons 4.0 : Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Vous pouvez copier et redistribuer le matériel sur tout support ou dans tout format et remixer, transformer et utiliser le matériel à toutes fins.
1. Licence
La Maison d'édition de l'Université de Silésie offre un accès libre et immédiat au contenu de ses revues sous la licence Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Les auteurs qui publient dans ce journal conservent tous les droits d'auteur et acceptent les termes de la licence CC BY-SA 4.0 susmentionnée.
2. Déclaration d'auteur
L'auteur déclare que l'article est original, qu'il a été écrit par l'auteur (et les co-auteurs), qu'il n'a pas été publié précédemment, qu'il ne contient pas de contenus illégaux, qu'il n'enfreint pas les droits d'autrui, qu'il fait l'objet des droits d’auteur qui appartienent exclusivement à l'auteur et qu'il est libre de tout droit de tiers, et que l'auteur a obtenu toutes les autorisations écrites nécessaires pour citer d'autres sources.
Si l'article contient du matériel d'illustration (dessins, photographies, graphiques, cartes, etc.), l'auteur déclare que les œuvres indiquées sont les siennes, qu'elles ne portent pas atteinte aux droits de quiconque (y compris les droits personnels, par exemple le droit de disposer de son image) et qu'il en détient tous les droits patrimoniaux. Il met les œuvres ci-dessus à disposition comme partie d'un article sous la licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".
ATTENTION : Sans déterminer la situation juridique du matériel d'illustration et joindre les consentements appropriés des propriétaires des droits d'auteur, la publication ne sera pas acceptée pour un travail éditorial. En même temps, l'auteur déclare prendre toute la responsabilité en cas de données incorrectes (y compris en ce qui concerne la couverture des frais encourus par la Maison d'édition de l'Université de Silésie et les réclamations financières de tiers).
3. Droits des utilisateurs
En vertu de la licence Creative Commons Attribution, les utilisateurs peuvent partager (copier, distribuer et transmettre) et adapter (remixer, transformer et construire à partir du matériel) l'article à n'importe quelle fin, à condition de le marquer de la manière spécifiée par l'auteur ou le concédant de licence.
4. Co-auteurs
Si l'article a été cosigné avec d'autres auteurs, la personne qui soumet ce formulaire garantit qu'elle a été autorisée par tous les co-auteurs à signer cet accord en leur nom et s'engage à informer ses co-auteurs des termes de cet accord.
En tant que l'auteur du texte proposé, je déclare qu'en cas de retrait du texte du processus de publication non convenu avec le comité de rédaction et/ou l'éditeur de la revue par moi-même ou de son renvoi parallèle à un autre éditeur, je m'engage à couvrir tous les frais encourus par l'Université de Silésie dans le cadre de la procédure de ma soumission (y compris, entre autres, les frais de publication des revues).